DAL “MANUALE DELLE INDULGENZE” 1
N. 1 – L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati [= le
conseguenze che restano delle nostre colpe, ndr], già rimessi quanto alla colpa [= col sacramento
della confessione, ndr], che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per
intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed
applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi [= tutte le preghiere, sacrifici,
mortificazioni e penitenze offerte a Dio come espiazioni dei peccati da Gesù, dalla Madonna e da
tutti i santi, ndr].
N. 2 – L’indulgenza è plenaria o parziale, secondo che libera in tutto (plenaria) o in parte (parziale)
dalla pena temporale dovuta per i peccati [= le sofferenze che sulla terra o in Purgatorio dovremo
affrontare per purificarci dai nostri peccati, ndr]
N. 3 – Ogni fedele può lucrare (= acquistare) le indulgenze sia plenarie che parziali per se stesso [=
in sconto delle pene dovute ai peccati suoi, ndr] oppure applicarle ai defunti a modo di suffragio [=
in sconto delle pene dovute ai peccati dei defunti, per abbreviargli l’intensità o il tempo delle pene
che soffrono nel Purgatorio, ndr]
1. PER LUCRARE QUALUNQUE INDULGENZA È NECESSARIO
• Intenzione almeno generale di acquisirla;
• Distacco dell’affetto dal peccato, anche veniale [= significa che non ci deve essere la volontà di commettere alcun peccato, neanche piccolo 2, ndr];
• Confessione sacramentale;
• Comunione sacramentale;
• Pater, Ave e Gloria secondo le intenzioni del Santo Padre.
2. OGGETTI SACRI A CUI È ANNESSA INDULGENZA PARZIALE SE SE NE FA USO DEVOTO
• Corona, scapolare e crocifisso indossati o venerati devotamente;
3. ALCUNE PARTICOLARITÀ
• Le preghiere prescritte devono essere recitate vocalmente;
• Una confessione vale per più indulgenze (ma una comunione e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre per una sola indulgenza);
• Si possono lucrare più indulgenze parziali al giorno (ma una sola plenaria);
4. QUATTRO CONCESSIONI GENERALI
Per i cristiani che tendono regolarmente alla perfezione della carità è data indulgenza parziale:
1. Pie invocazioni elevate a Dio con umile fiducia dal cristiano fatte durante lo svolgimento
del suo lavoro o nel tollerare le avversità (= giaculatorie fatte durante la giornata).
!1 Promulgato in ottemperanza alla lettera di Papa Paolo VI “Indulgentiarum doctrina ” (= dottrina delle
indulgenze) dell primo Gennaio 1967. Aggiornato dalla Santa Sede nel 1999.
!2 Anche se, necessariamente, qualche peccato almeno veniale, finché siamo sulla terra, lo commettiamo. Ma
non dobbiamo volere offendere Dio neanche con una semplice bugia. Questa è l’intenzione del testo.
2. Cristiano che dona se stesso o i suoi beni, per spirito di fede, ai fratelli che si trovano in
necessità (= elemosina).
3. Cristiano che si priva di qualche cosa a lui gradita o lecita in spirito di penitenza (= sacrifici
e mortificazioni).
4. Cristiano che rende testimonianza della fede pubblicamente davanti agli altri.
1. CONCESSIONI PARTICOLARI
A) INDULGENZA PLENARIA
5.1 Almeno mezz’ora di adorazione al Santissimo Sacramento;
5.2 Via Crucis;
5.3 Rosario recitato in Chiesa (oppure in ogni luogo se recitato in famiglia o in comune);
5.4 Recita dell’inno Akathistòs (in Chiesa);
5.5 Almeno mezz’ora di lettura della Parola di Dio;
5.6 Ritiro spirituale di almeno tre giorni;
5.7 Indulgenza in articulo mortis: data dal sacerdote con benedizione apostolica ad hoc (si
amministra con il sacramento dell’unzione; per questo è così importante chiamare il sacerdote
prima della morte della persona);
5.8 Partecipazione all’adorazione della Croce il Venerdì Santo;
5.9 Recita in Chiesa dell’inno allo Spirito Santo “Veni Creator” il primo dell’anno e a
Pentecoste;
5.10 Recita in Chiesa il 31 Dicembre dell’inno Te Deum;
5.11 Rinnovazione delle promesse battesimali nella Veglia pasquale e nell’anniversario del
proprio Battesimo con formula propria;
5.12 Recita del Rosario in cimitero e preghiera, anche solo mentale, per i defunti dal primo
all’otto Novembre (per le anime del Purgatorio);
5.13 Visita di una Chiesa o Cappella nel 2 Novembre e recita del Pater e Credo;
5.14 Visita dei seguenti luoghi sacri con recita di Pater e Credo:
• Una delle quattro basiliche patriarcali romane, facendo un atto di sottomissione al Papa;
• Una basilica romana minore, una volta l’anno, o nella festa dei Santi Pietro e Paolo o nella Solennità del
Patrono o il 2 di Agosto;
• Chiesa Cattedrale di ogni diocesi o nella festa dei Santi Pietro e Paolo o nella Solennità del Patrono o il 2
di Agosto;
• Santuari, una volta all’anno oppure nella festa del Patrono;
• Chiesa Parrocchiale il 2 Agosto o nella festa del Patrono;
• Chiesa o altare nel giorno della dedicazione;
B) INDULGENZA PARZIALE
5.1 Visita del Santissimo sacramento;
5.2 Recita degli inni Adoro devote o Tantum ergo o O Sacrum Convivium a Gesù sacramentato;
5.3 Comunione spirituale

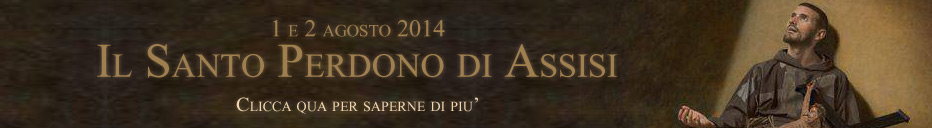

 Feed RSS
Feed RSS
